Mappe
di John Freeman
La nave di Teseo, maggio 2021
Traduzione a cura di Vera Linder (testo originale a fronte)
pp. 176
18,00 € (cartaceo)
Non ci fidiamo della luce. È stato troppofacile reindirizzarla. Ci orientiamo attraversola notte, seguendo il vento, prestando orecchio airumori improvvisi, in attesa del sapore di cenere.(“Beirut” p. 23)
Cosa ci spinge a scrivere di noi in versi? Vogliamo assecondare una pulsione interiore, un eccesso di interiorità, un ricordo che temiamo sbiadisca? Penso che ogni lettore di poesia si ponga questa domanda al momento di iniziare la lettura di una nuova raccolta, che sia di un autore già noto, amato, o appena scoperto. E la risposta non è mai semplice, perché è molto complesso leggere poesia come il tentativo di espressione di qualcun altro piuttosto che il riflesso di noi stessi nelle parole di quel qualcuno. Si tenta costantemente di individuare quella frase, quell’espressione, quella rima che parli al noi interiore e funga da raggio di luce per quella voce che non riusciamo a esprimere da soli.
Quello che, invece, spesso si cerca quando non si riesce a comprendere e fare proprio un linguaggio poetico è la struttura del testo. Ci appare di supporto alla comprensione, alla ricerca di senso, di quel non detto che caratterizza la scrittura lirica, il linguaggio per eccellenza dell’allusione e della suggestione. Struttura, musicalità, termini quotidiani; tutti elementi che danno al lettore l’impressione di arrivare più vicini al messaggio. Ed è questo messaggio rincorso la “X” rossa che indica il tesoro nelle mappe di pirati e impavidi avventurieri. La cartografia di questa ricerca emerge come elemento portante nella costruzione della raccolta di John Freeman, Mappe, uscita da poco in Italia per La nave di Teseo e che introduce anche qui lo scrittore, editor e critico californiano sotto una nuova luce. Come le tessere di un puzzle sparse disordinatamente su un tappeto e la cui illustrazione non è facile da ricostruire, la lettura delle sue poesie si scontra con un interrogarsi costante e un continuo tentativo di collegare fatti e informazioni personali dell’io lirico.
In Mappe, Freeman compie un viaggio in versi dentro di sé, nello spazio della sua interiorità e del visibile. In un moto instancabile, trasportata da treni, autobus, macchine, la voce poetica si muove accompagnata da leitmotiv ben precisi e spesso binari. La vita e la morte, in primis; l’abbandono attivo di un luogo e l’abbandono subito con la perdita di una persona amata (qui, della madre); il movimento del tempo, delle cose, di cuore e mente che raramente procedono in parallelo; la dolcezza del ricordo e l’impronta spietata e dolorosa di esso; il camminare nella storia, quella più intima e quella più inevitabilmente condivisa. L’autore percorre luoghi reali, come l’America e la California della sua infanzia e gli spostamenti dei suoi familiari, esplorando l’idea stessa di mobilità dell’individualità nordamericana, spesso guidata da flussi e da un senso di entropica irrequietezza nello spostarsi. Tra i luoghi dell’umano presenti nei testi della raccolta, ci sono il lutto e la guerra, il primo in una delle sue forme più complesse della perdita di un genitore; la seconda in quanto avvenimento di portata globale, ma, ciononostante, ugualmente incomprensibile se pensata razionalmente. Riflette sulla vita che non è “solo una vita, ma l’involucro // del valore che le attribuiamo” (“Monete”, p. 61). Questo “vessel” che la vita dovrebbe essere, trasposto poeticamente con “involucro” dalla traduttrice Vera Linder, trasporta molto di noi stessi e di tutto il resto. Il dolore, l’incomprensione della guerra e della perdita fanno vacillare il senso stesso dell’essere umani e di quella vita che, “persa in latitudine, allora cade dalla // mappa” (“Misure mancanti”, p. 131).
La cartografia esistenziale che Freeman traccia nel suo percorso poetico attraversa anche luoghi familiari, quei luoghi che chiameremmo casa perché sono il “posto dove si torna” (“Blackout”, p. 99). Ma il senso di casa, seguace di quella mobilità irrequieta e quel senso di movimento malamente placato non è un concetto che l’io poetico esaurisce facilmente. Quello spazio nativo di ritorno, confortevole al ricordo, è un non-luogo; costruisce una geografia interiore dell’io che lo rende alienato tra sentimenti, dolori, memoria e spazi visibili. La complessità dell’io si riflette sullo spazio dell’animo e della realtà che la casa occupa. Un dialogo duale si instaura per evadere la confusione che questa assenza di linearità genera. L’io è incerto, procede a tentoni per darsi risposte valide a cui può aggrapparsi.
Per te dueluoghi sonoun luogo,tu comprendi che questasensazione di vertiginea volte significache sei a casa.(“Ore d’inglese, tre consigli”, p. 115)
Casa, luogo, spazio… Possiamo quindi dire che Freeman instaura un dialogo diretto con il dentro e il fuori dell’umano, quel suo mondo più intimo e la Terra che calpesta ogni giorno. La sua poesia è una poesia dello spazio a tutti gli effetti; prende in analisi moltissime sfaccettature di esso in senso stretto. Spazi della mente, del cuore, della vita si accompagnano agli spazi tracciabili su mappe e cartine, il che provvede a fornire una geografia dell’umano a tutto tondo, pur rispettando sempre la voce poetante intrisa di storia personale dell’autore. È quindi forse anche una poesia dello spazio “apparente”, dove per apparenza si intende quella tracciabilità impossibile che si ritrova nella geografia che ognuno di noi costruisce per sé e dentro di sé. Freeman stesso riflette sull’esigenza condivisa di “rimappare il mondo” [“Parigi (Presa della Bastiglia)”, p. 157], una smania di controllo e di comprensione che guida le persone a legarsi ai luoghi indissolubilmente, spesso in modo inconsapevole e inaspettato. La non-casa, il senso di appartenenza e la memoria, persa o trattenuta, salgono qui sul treno dell’individuo e procedono con lui accompagnandolo nelle sue (in)finite rivoluzioni terrestri.
[…] tutto quello che potevo fare allora era starevicino alla fiamma, e stupirmi delle vesciche.(“L’estate del 1995”, p. 53).
Lucrezia Bivona

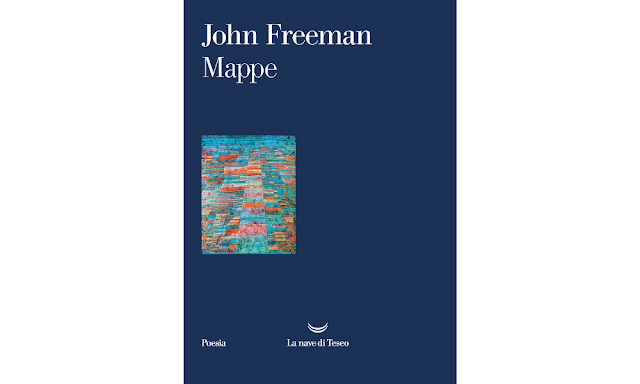
Social Network