Quando ero piccolo non ho mai saputo da dove venisse mia madre: dove fosse nata, chi fossero i suoi genitori. (p. 11)
Il colore dell’acqua, il racconto a due tracce di James McBride, è il tentativo di un uomo di colmare i vuoti della sua storia famigliare e il confronto con sentimenti complessi nel percorso di ricerca della propria identità. Dopo il successo del romanzo L’emporio del cielo e della terra – preceduto da The Good Lord Bird e Il diacono King Kong – un paio di mesi fa Fazi ha portato in libreria il bestseller di McBride uscito per la prima volta in inglese nel 1995, affidando la traduzione a Roberta Zuppet che si confronta con una storia a due voci, quelle dell’autore e della madre.
Il colore dell’acqua è un racconto intimo che non cede mai al sentimentalismo, nato dall’esigenza di scoprire la verità sul passato nebuloso della madre che pagina dopo pagina emerge nel dialogo con lei e si intreccia, tra le altre cose, alla questione razziale, alle coppie miste, alla povertà, al riscatto. Una storia intima e personale, le cui ricerche sono durate quattordici anni, che ne racconta una più grande, dagli anni Venti a metà anni Novanta, e come Rachel Deborah Shilsky sia diventata Ruth McBride. Ebrea, cresciuta con un padre particolarmente duro, una madre invalida amatissima e una sorella più piccola, Rachel cessa di esistere nel momento in cui si innamora di un nero, Dennis McBride: ripudiata dalla famiglia – dal padre – sceglie di diventare Ruth McBride, prendendo il cognome del marito; una scelta definitiva – viene osservato lo shiva come se Ruth fosse morta – che la esclude per sempre dalla famiglia d’origine e produce una rottura che non sarà mai più riparata e che suo figlio James molti anni dopo cerca di comprendere, nel tentativo di conoscere il passato della madre, le sue stranezze, certe ambiguità del loro comune passato, il dolore per la perdita del primo marito. Una storia di radici, dunque: quelle che James va cercando, quelle che Rachel ha reciso.
Il suo passato era sempre stato un mistero e rimase tale anche dopo la morte di papà, ma quello che si era lasciata alle spalle era così importante, così definitivo, che non riuscì mai a cancellarlo del tutto: la disgregazione della sua famiglia ebrea, il senso di colpa per aver abbandonato la madre, la separazione dalla sorella, la scomparsa tragica e inaspettata del primo marito, un uomo che amava con tutta sé stessa. (p. 137)
Il racconto di Ruth, che si alterna alla narrazione dell’autore, è frammentario e doloroso, a costruire una storia che si muove su piani temporali diversi, mai sentimentale ma di fronte alla quale è impossibile restare indifferenti. McBride maneggia una materia complessa il cui centro nevralgico è il tema dell’identità razziale, gravata dal peso di sentimenti compositi: nella ricostruzione del passato di Ruth si intrecciano dunque il percorso di James, le ribellioni, la confusione, le difficoltà economiche che solo da adulto ha compreso davvero, il razzismo, la droga, il riscatto, l’intransigenza della madre, il caos famigliare.
Non ci consideravamo poveri, indigenti o miserabili perché, essendo bambini, ci mancavano i termini di paragone con il mondo esterno. Però quando diventammo grandi e ci sparpagliammo in giro come adolescenti e studenti universitari, cominciammo a cogliere le differenze, e l’universo che la mamma aveva creato con tanta fatica iniziò a crollare. (p. 86)
Da un punto di vista puramente narrativo, è come se McBride tenesse nelle mani due storie, entrambe potenti, quella di una donna ebrea ripudiata dal padre che si costruisce una vita nella comunità nera, e quella di un ragazzo che fa i conti con la razza, teso tra due mondi, alla ricerca di modelli di riferimento in una società ancora profondamente razzista e discriminante. Ecco, l'autore tiene entrambe queste storie e riesce a restituirle al lettore dando a ognuna la dovuta dignità e spazio, senza edulcorare, assumendosi le proprie responsabilità e prendendo atto anche delle proprie mancanze.
Il colore dell’acqua è dunque un memoir particolarmente denso e stratificato che, pur partendo da una vicenda personale, apre a suggestioni più universali ragionando, come si è sottolineato, sul tema complesso dell’identità, dell’appartenenza a una comunità attraverso legami che vanno oltre il sangue e il colore della pelle, sul significato di famiglia, la malleabilità del ricordo, lo sguardo infantile sulle cose e la brutalità della scoperta adulta. Stratificato, dicevo, per la molteplicità degli spunti che si diramano dal centro nevralgico della questione razziale, da punti di vista differenti: l’indagine di James sul passato della madre e il loro percorso, si lega infatti inevitabilmente anche alla storia della famiglia materna, alle radici ebraiche, alla violenza e i soprusi subiti dalla nonna e, più in generale, al ritratto di un determinato contesto storico e sociale.
Per il modo in cui Tate la trattava, oggi verrebbe definita “una donna vittima di abusi”. Allora eri soltanto “una moglie”. E nel Sud un uomo poteva fare alla moglie quello che gli pareva. Soprattutto se lei era un’ebrea invalida e lui un rabbino. L’uomo può deriderla, insultarla, urlarle dietro e prenderla a schiaffi. Può persino uscire con un’altra sotto i suoi occhi. (p. 164)
Dalle origini ebraiche del ramo materno alla fede cristiana, il percorso umano di James passa anche per le riflessioni sulla fede e ciò che ha rappresentato nella sua famiglia e nella sua stessa vita, per suo padre, per l’eredità che ha lasciato alla sua comunità. Ecco, Il colore dell’acqua è anche una storia di padri, di un legame nato dal sangue o per scelta, ugualmente forte e determinante, passato per il dolore, la perdita, lo smarrimento, la rabbia. Un racconto che forse è prima di tutto una riconciliazione: con il proprio passato, con i segreti e i fantasmi di quello della madre, con la rabbia e certe scelte. Il percorso di James non sarà infatti sempre lineare, la numerosa famiglia McBride attraversa tempeste, crisi talvolta insanabili, traslochi, accuse, difficoltà e battute d’arresto. Sotto lo sguardo vigile e intransigente di Ruth e l’eredità spesso ingombrante delle due figure paterne, James, i fratelli e le sorelle crescono e fanno errori, si scontrano con il razzismo a vari livelli, danno voce alla rabbia e qualche volta si ribellano al controllo materno creando crepe nella famiglia che paiono insanabili.
«Devi scegliere tra quello che il mondo si aspetta da te e quello che vuoi per te stesso» (p. 136)
Ebreo da parte materna, figlio di una donna bianca che vive nella comunità afroamericana, nero, cattolico: l’identità complessa di James McBride rispecchia le complessità stesse di un mondo in cui non è stato facile trovare il proprio posto, profondamente discriminante, pericoloso. È sui colori del mondo che l’autore concentra la sua riflessione più profonda e accorata, sulle difficoltà di comprendere davvero la propria identità, passando per quella rabbia e ribellione che ne ha segnato la gioventù, fino a una più matura consapevolezza e accettazione. Teso tra mondi diversi, nessuno di questi davvero al riparo dalla discriminazione:
Mi ci vollero anni per rendermi conto che il nebuloso “mondo dell’uomo bianco” non era libero come sembrava; che contavano anche i fattori di classe, fortuna e religione; che spesso i bianchi avevano problemi di gran lunga più gravi dei miei; che non tutti gli ebrei sono come mio nonno e che anch’io sono in parte ebreo. Eppure la bandiera dei colori era ed è tuttora il maggior ostacolo nella mia mente. Per eliminarlo decisi di starne alla larga e di volare da solo. (p. 214)
Il racconto di McBride, per sua natura intimo e accorato, non solo tocca l’emotività del lettore, ma – ciò che più conta – ne stimola la riflessione, aprendo le porte su una realtà complessa e per molti di noi difficile da comprendere, riuscendo a fondere le peculiarità del memoir con il rigore dell’inchiesta giornalistica, che si tratti di sollecitare il racconto della madre o di mettersi fisicamente sulle tracce del suo – loro – passato tornando dove tutto ha avuto inizio, a Suffolk, in Virginia, alla ricerca dei testimoni superstiti. E pure laddove pare cedere a certi istinti moraleggianti, Il colore dell’acqua resta ancora oggi un testo importante per comprendere non solo l’America di primo Novecento, le sue storture e contraddizioni, ma anche certe istanze della stessa società contemporanea. Quando è sempre più difficile, purtroppo, tornare a sognare una società post razziale.
«Di che colore è lo spirito di Dio?» «Di nessun colore», disse. «Dio è del colore dell’acqua. L’acqua non è di nessun colore». (p. 53)
Debora Lambruschini

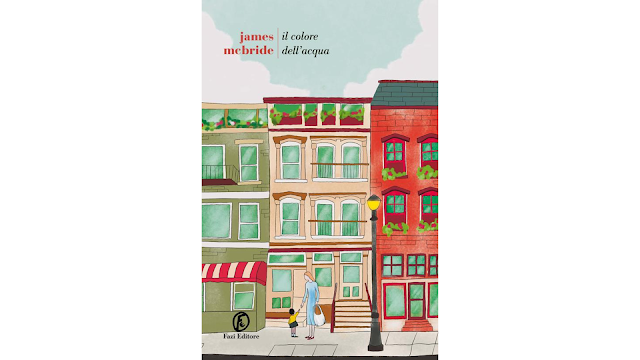
Social Network