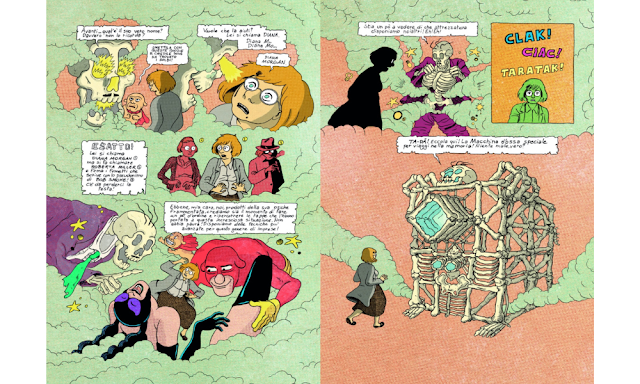La verità è che il Mediterraneo è un caso unico al mondo: perché è un mare semichiuso con una densità di popolazione tra le più elevate del pianeta. È un mare incastrato tra le terre, un “campo di golfi”, come lo descrisse ormai novant’anni fa George Simenon nella serie di reportage che scrisse mentre veleggiò per tre mesi lungo il bacino. È anche un oceano in miniatura, perché vede esplodere in modo esponenziale tutte le criticità che riguardano le grandi massi d’acqua del pianeta. (p. 124)
I cambiamenti che riguardano la superficie terrestre e l’atmosfera sono ben noti, perché sono visibili e alla portata ormai di tutti, ma quelli che riguardano il mare - altrettanto preoccupanti - rimangono pressoché nascosti, visibili solo a chi ha vissuto e ancora vive di mare. È per questo motivo che, rispetto agli altri aspetti del cambiamento climatico e dell’inquinamento (scioglimento dei ghiacciai, eventi meteorologici estremi, deforestazione, piogge acide e altro ancora) i vari governi si sono mossi tardi o comunque in maniera non adeguata quando sono stati lanciati i primi campanelli d’allarme da parte di chi studia il mare o vive di mare, come biologi marini e pescatori. Peggio ancora: il nostro mare è “un lago” su cui si affacciano alcuni Stati, quelli nordafricani, che continuano a ignorare gli inequivocabili segnali dei cambiamenti irreversibili del Mediterraneo e della perdita della sua meravigliosa e unica biodiversità.
Stefano Liberti, giornalista e film-maker, da anni si occupa di reportage di politica internazionale e in questo libro, ci accompagna in un’affascinante traversata nel mare nostrum, ormai Tropicus, alla scoperta - come recita il sottotitolo - di un mare che cambia. Con un piglio accessibile, che incanta e che cattura chi legge, il giornalista ci mostra, spostandosi da una costa all’altra del bacino, la metamorfosi del Mediterraneo, un dramma senza eguali sì, ma senza dimenticarsi di lasciare aperto qualche spiraglio di speranza.
Il risultato è un libro davvero interessante, arricchente e scorrevole: è un ibrido tra il reportage, il racconto di viaggio e di incontri, interviste a pescatori, a ricercatori e anche ad artisti che in maniera creativa cercano di valorizzare la ricchezza marina. Ogni luogo ha una sua specialità e un suo dramma da affrontare che diventa però una sorta di prisma di una serie di cambiamenti che rendono evidente il fatto che il Mediterraneo abbia raggiunto il suo punto di non ritorno.
Quali sono le cause di questa metamorfosi del nostro mare? La risposta richiede un’argomentazione articolata che l’autore ci fornisce sin dalle prime pagine: è vero che siamo di fronte a un serpente che si morde la coda, per cui ogni aspetto è causa e insieme conseguenza di certi fenomeni e che, probabilmente, il cambiamento climatico in atto è un «acceleratore di crisi. Si innesta su problemi preesistenti e li acuisce» p. 38), ma è anche vero che il maxi allargamento del Canale di Suez nel 2015 (processo iniziato già nei decenni precedenti, in verità) e lo scarico delle acque di zavorra hanno rappresentato la via privilegiata all’importazione e alla proliferazione di specie aliene aggressive che stanno minacciando la speciale biodiversità del nostro Mediterraneo.
Quello delle specie aliene è un termometro che ci indica quanto sta cambiando il Mediterraneo. “Il nostro è ormai un mare subtropicale. Non si tratta di qualcosa che avverrà in futuro, ma che è già avvenuto”, dice Azzurro sgranando gli occhi per dare la giusta enfasi alla sua affermazione. “Negli ultimi vent’anni abbiamo visto un significativo incremento di nuove introduzioni, accompagnato da una più marcata capacità invasiva delle specie introdotte. […]le specie autoctone sono destinate a perire. Le nicchie ecologiche non tollerano la presenza di due specie in competizione: quella con caratteristiche di maggiore forza e capacità di adattamento prevarrà. (pp. 20-21)
Il biologo marino Ernesto Azzurro, intervistato dal nostro autore, spiega che il danno è ormai in atto, in particolare nel Mediterraneo orientale, dove le specie aliene hanno sostituito quelle autoctone. Gli esempi eclatanti più vicini a noi sono due: il famigerato granchio blu nelle sue due varianti ha spazzato via quello arancione delle nostre coste e sta facendo razzia degli ambienti lagunari, come le acque basse delle tunisine isole Kerhennah e del Delta del Po, famoso per la pesca delle vongole di Goro. Estremamente pericolosi per la ricchezza dei nostri fondali e dei nostri vivai marini sono anche il pesce scorpione, il pesce palla maculato - che ha praticamente distrutto la biodiversità marina di Cipro -, innumerevoli meduse più o meno grandi, la caulerpa taxifolia, la cosiddetta “alga assassina” che si sta sostituendo alla preziosissima posidonia, vero vivaio per la riproduzione di centinaia di specie di pesci. Di fronte alle proprie colpe l’Egitto minimizza, sottolineando invece i vantaggi economici che l’apertura del Canale di Suez ha rappresentato per il commercio mondiale: «L’8 percento dell’intero commercio mondiale passa di qui. Ma da quella che è ormai diventata un’ampia apertura non transitano solo le navi. Il Canale di Suez è oggi una delle principali porte d’ingresso per vari tipi di organismi che non dovrebbero esserci» (p. 16). Certamente non possiamo incolpare solo l’Egitto se adesso il nostro mare sia diventato un mare tropicale, perché, per usare la felice espressione di Platone nel Fedone che aveva paragonato il Mediterraneo a uno stagno abitato da diverse rane che vi abitano lungo il bacino, è pur vero che ogni Stato che vi si affaccia ha la sua cultura peculiare e i suoi interessi che non tengono in considerazione l’impatto ambientale di una pesca di rapina. L’Unione europea infatti applica diverse restrizioni alla pesca, soprattutto quella a strascico, ma spesso non sono efficaci, anzi risultano deleterie, perché vengono elaborate senza interpellare chi ha fatto del mare la sua fonte di sostentamento, mentre stati come Egitto, Tunisia, Libia continuano a scorrazzare con i loro pescherecci e barchini - talvolta armati -, arrogando diritti di pesca aggressiva anche nelle acque internazionali.
Tropico Mediterraneo è una lettura estremamente coinvolgente, non soltanto per l’argomento in sé, ma per una serie di felici combinazioni: l’agilità dell’intervista, il racconto dei luoghi, il carisma e il fascino di cui sono ammantati alcuni pescatori intervistati, come i fratelli Lombardi nel Canale di Sicilia, la meraviglia che suscitano certe opere d’arte, come quelle di Mohamed Amine Hamouda che sulla spiaggia tunisina di Gabès, crea addirittura tessuti utilizzando materiale naturale dell’oasi, i drammatici racconti di perdite naturalistiche, fino alle chicche storiche sulle vongole di Goro e del gambero rosso di Mazara del Vallo.
Per questo motivo il libro andrebbe letto veramente da tutti, da chi ama il mare, da chi è sensibile all’impatto ambientale in generale, dagli insegnanti che vogliono proporre ai loro alunni e alle loro alunne nelle ore di educazione civica (e perché no, visto il contenuto di alcune pagine, anche nelle ore di didattica orientativa) pagine coinvolgenti, che mostrino la metamorfosi del nostro amato mare, senza però far perdere di vista i segnali di speranza contenuti nel libro. L’esempio di biologi, pescatori, artisti, studiosi di diverse nazionalità che cercano strade alternative per non far morire l’economia legata al mare, come la ricerca e l’applicazione di tecniche per trasformare la corazza del granchio blu in fertilizzante da usare in agricoltura, quelle per conciare la pelle del vorace pesce palla per ottenere scarpe e borse, oltre alle piccole conquiste in ambito internazionale come la realizzazione di aree marine protette, costituiscono importanti esempi di resilienza, creatività e amore incondizionato per il mare.
E penso che questo patrimonio incredibile, questo Mediterraneo così piccolo ma così diverso nei paesaggi e nelle dinamiche, questo oceano in miniatura, non è solo uno stagno intorno al quale si agitano milioni di rane spesso in lotta tra loro, ma anche uno specchio in cui dovremmo rifletterci e che ci dovrebbe far riflettere sul ruolo che noi esseri umani abbiamo avuto nella modifica degli ecosistemi e nella loro progressiva degradazione. […] Perché quanto accade oggi in questo mare indica una sola cosa: che la nostra unica via di salvezza è riconnetterci con quegli ecosistemi che abbiamo pensato di sfruttare e che oggi si ribellano, mandandoci segnali inequivocabili. (p. 188)
Marianna Inserra


.png)



.png)

.png)

.png)