“Storia di una ladra di libri”, ristampa datata 2014 del
bestseller “La bambina che salvava i libri” di Markus Zusak è un caleidoscopio
di colori, fotogrammi, sentimenti, accostati l’uno all’altro, ritmicamente
cadenzati in 562 pagine da voltare una ad una, con curiosità, accoramento,
rassegnazione e stupore.
Ci sono i colori, quelli che la Morte, voce narrante di rara
e cupa vitalità (a ossimorico dispetto della sua identità, si potrebbe
osservare) nel romanzo, racconta con dettagliata cura e che riguardano ogni sua incursione sulla Terra: e negli anni
Quaranta del Novecento, la Morte ha un gran bel daffare, come ammette lei
stessa. È lei ad affermare:
L’interrogativo che devi porti è: che colore assumerà ogni cosa nell’istante in cui verrò da te? Che cosa dirà il cielo?La gente tende a notare i colori di una giornata solo all’inizio e alla fine, ma per me è chiaro che in un giorno si susseguono un’infinità di sfumature e tinte, in ogni istante. Una singola ora può essere composta da migliaia di colori diversi. Gialli cerei, azzurri plumbei. Tenebrosa oscurità. Nel mio lavoro mi picco di notarli tutti.
Fin dalla prima inquadratura di un romanzo quanto mai
cinematografico (non a caso, l’adattamento per il grande schermo è datato
2014), si comprende che “Storia di una ladra di libri” è la narrazione della
Morte. Non solo in quanto voce narrante, ma anche e soprattutto come
protagonista assoluta delle pagine: la Morte si prende il fratellino di Liesel,
la Morte (o la sua anticamera sottoforma di campo di concentramento) le sottrae
la madre; e, piano piano, ogni certezza, ogni rifugio umano e fisico della
bambina soccombe al richiamo della Fine. E non potrebbe essere altrimenti, per
una storia ambientata nella Germania nazista, in piena Seconda guerra mondiale:
Nel corso degli anni ho visto tanti giovani che credono di correre gli uni contro gli altri. Non è così. È verso di me che corrono.
Ma la Morte può essere una compagna di viaggio piacevole,
per un lettore che si avventura tra le pieghe dolorose di una storia inventata
ma duramente verosimile dove il nemico principale è rappresentato non dal
pericolo di soccombere ma dal rischio, ancor più terribile, di rimanere vivi.
Lo si capisce bene nella descrizione piena di dolcezza e
disperazione che la Morte riserva alla strage di ebrei nel campo di Auschwitz
del 23 aprile 1942:
Credimi, ti prego, quando ti dico che quel giorno raccolsi ogni anima come se fossero neonati. Addirittura baciai guance esauste, velenose. Ascoltai le loro ultime, soffocate grida, le loro parole francesi. Osservai le loro visioni amorose e le liberai dal timore. Li portai via tutti, e se mai ci fu una volta in cui avevo bisogno di distrarmi, era quella. Guardavo il cielo su in alto, assolutamente costernata. Osservavo il cielo mutarsi da argento a grigio al colore della pioggia. Persino le nuvole tentavano di sembrare altre cose.Erano francesi. Erano ebrei. Erano te.
E quell’“Erano te” è un
j’accuse a cui nessuno di noi può sottrarsi; nemmeno dopo settant’anni,
nemmeno dopo un milione di anni.
È un dito magistralmente puntato contro il volere di alcuni,
la complicità di molti, l’indifferenza di quasi tutti.
Ma, accanto ai colori che la Morte associa ad ogni sua
incursione terrena, ad ogni saccheggio di anime, ci sono veri fasci di luce,
fari che illuminano per un attimo la spietatezza di un romanzo che non fa
sconti. È il caso di Hans Hubermann, l’uomo dagli occhi d’argento, padre adottivo della ladra di libri, Liesel. Per descriverlo,
poche immagini che spezzano il respiro e gonfiano il cuore:
La maggior parte della gente non notava Hans Hubermann. Lo considerava una persona insignificante. Certo, la sua abilità di decoratore era eccellente. Il suo talento musicale era superiore alla media. In qualche modo però, e senza dubbio avrai incontrato altri individui come lui, aveva la capacità di restare sullo sfondo persino se era il primo di una fila. Era lì. Ma non lo si notava. (…) Tuttavia, il suo aspetto insignificante induceva in errore. In lui c’era indiscutibilmente del valore, che non sfuggì a Liesel Meminger (talvolta nella specie umana il bambino è decisamente più acuto dell’adulto). (…) Liesel notò la singolarità degli occhi del suo padre adottivo. Erano fatti di bontà e d’argento. Di un argento soffice e liquido. Osservando quegli occhi Liesel comprese che Hans Hubermann valeva molto.
Si alzarono entrambi e andarono in cucina, e attraverso la finestra appannata e gelata videro strisce di luce rosea sui cumuli di neve dei tetti della Himmelstrasse.«Guarda che colori» disse Papà. Difficile non amare un uomo che non soltanto nota i colori, ma ne parla.
L’episodio più toccante dove si comprende da vicino il
valore di un uomo come Hans Hubermann è descritto a pagina 405, quando egli si
china a offrire un pezzo di pane ad un ebreo anziano, durante una sfilata di
prigionieri per la strada principale di Molching, diretti a Dachau:
Quando il pane passò da una mano all’altra l’ebreo si lasciò scivolare a terra, cadendo sulle ginocchia, e abbracciò gli stinchi di Papà. Vi affondò il viso, per ringraziarlo.Liesel guardava.Con gli occhi pieni di lacrime vide l’uomo scivolare ancora più giù, spingendo indietro Papà per piangere fra le sue caviglie.Passavano frattanto altri ebrei, guardando tutti quel piccolo, futile miracolo.
Ed è così che mi piace pensare a questa storia crudele,
intrisa di sangue e amore umano. Un inno alla forza delle parole e al valore
dei gesti: sottrarre un libro da un rogo nazista; donare un racconto pieno di
disegni e parole, che passa dalla mano di un fantasma ebreo a quella di una
ragazzina tedesca; scrivere la propria storia su un libriccino nero, dentro uno
scantinato, mentre fuori piovono bombe, nel tetro 1943: un piccolo, futile
miracolo.
Barbara Merendoni
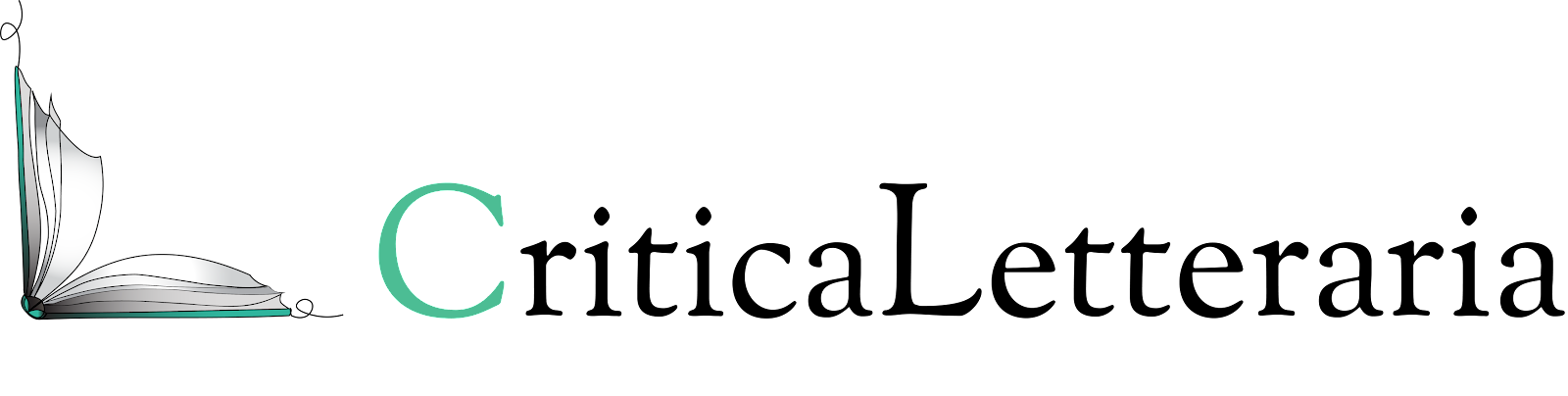

Social Network