Catania bene
di Sebastiano Ardita
Mondadori, 2015
pp. 192, € 17
di Sebastiano Ardita
Mondadori, 2015
pp. 192, € 17
Catania è una città complicata e bellissima; non lo dico perché ci sono nata, lo dico perché questa è la verità. È complicata nelle dinamiche, nelle contraddizioni, negli equilibri. E forse è bellissima proprio per questo. La luce impietosa ne colpisce ogni dettaglio e ne svela ogni ruga, ma i palazzi, di pietra nera vulcanica, e le strade, prima di restituire parte di quella luce, la tengono per sé, senza chiedere permesso. E questo è anche quello che succede nelle stanze, nei bassi dei quartieri popolari, nelle strade che come un labirinto ti conducono al centro e da nessuna parte in particolare, in questo senso di perdersi e di ritrovarsi ti capita di intravedere l’anima di qualche grande cortile d’epoca, uno scorcio appena su giardini inaccessibili. La città è lo specchio dei suoi rapporti di forza e di potere. Lo sapeva De Roberto, che ne ha sondato sfarzi, incesti politici e ambizioni risorgimentali, con lo zoom puntato sulla famiglia Uzeda, e lo sanno i catanesi, ma sembrano non curarsene. Tutti ostentano l’abito migliore, e hanno la sottoveste sgualcita.
L’esercizio alla rimozione è così abusato, che i "testimoni" illustri possono anche leggere i nomi di alcuni personaggi sulla cronaca locale e stupirsi di intrecci di cui sono stati protagonista la sera precedente. Nel libro di Sebastiano Ardita, che indaga queste dinamiche da giovanissimo sostituto Procuratore, divenendo poi componente della Direzione distrettuale antimafia e infine consulente della Commissione parlamentare antimafia della XIII Legislatura, (attualmente ricopre il ruolo di Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Messina) la matassa si dipana con grande chiarezza. Una chiarezza che è da sempre così evidente e così complicata, da far dire a qualcuno che sono cose già dette. Invece no. Senza troppi giri di parole, ma sondando le dinamiche precise di un mondo parallelo e ben radicato in ogni salotto “alto”, Ardita fornisce una cartina di tornasole di quello che tutti sanno sempre molto bene ma poi dimenticano.
Ardita, da uomo di legge che ha piena consapevolezza delle dinamiche della strada, con una penna arguta e chiara, fornisce anche le motivazioni del facile restyling che la Cosa Nostra catanese riesce a fare negli anni, ne racconta i momenti clou, i nodi di svolta e quel codice di “rispettabilità” e “onore”, che ancora fa esclamare, dietro qualche portone o tra le signore che si incontrano con la sporta della spesa piena, che a loro non succederà nulla, perché “quelli del quartiere” non si toccano. Una mentalità parastatale che ha anche un che di snobismo lobbistico, nelle pennellate periferiche o nelle chiazze larghe del centro, di una città, in cui prima di tutto conta l’apparenza.
La vicenda esamina l'ascesa di Cosa Nostra nella città siciliana, a cavallo tra gli anni Settanta e i giorni nostri. Non mancano riferimenti a fatti, persone, protagonisti che fino all’inizio degli Ottanta si dipanava tra un versante più interno alle dinamiche di Cosa Nostra e uno più solitario. Indagando ad esempio l’uccisione dei tre carabinieri che scortavano, su una Mercedes non blindata, Angelo Pavone, come messaggio chiaro dato a Nitto Santapaola, perché la smettesse di credere che una città come Catania potesse “governarla” da solo, e in seguito al quale si fecero invece più fitti i rapporti tra Nitto e lo Stato, in una sorta di accordo e di patto di non belligeranza per poter assicurare a questo filone di criminali una etichetta di mafia buona e rassicurante, mentre tutto intorno si aggregavano i fuoriusciti di Cosa Nostra.
L’ascesa criminale di Santapaola assume contorni netti nella Cosa Nostra catanese. Così se nel versante occidentale dell’isola la mafia uccideva gli uomini delle istituzioni, in quello orientale andava a braccetto con esse. Il culmine di tanta violenza lo si ebbe nelle stragi cruente di quegli anni, in particolare nella strage di via dell’Iris. Quando gli investigatori entrarono per il sopralluogo, all’interno di una stanza trovarono tanto di quel sangue a terra che per camminare sul pavimento occorrevano gli stivali. Ma Santapaola non era lì, ed ebbe tempo e modo di organizzare la risposta per chiudere definitivamente la partita con il rivale.
Santapaola, in realtà, non disdegnava il metodo palermitano fuori da Catania, e così uccidere uomini delle forze dell’ordine, purché non si facesse in città, andava bene anche a lui. Nell’82 si conclude la prima guerra di mafia interna a Cosa Nostra catanese, e i rivali santapaoliani furono guidati da Salvatore Pillera. Il quadro della mafia catanese vedeva quindi da una parte Nitto Santapaola e dall’altra il clan Pillera-Cappello. Nel gioco di rapporti che si era venuto a creare arrivò qualcuno a scombinare gli intrecci e i legami, Carlo Alberto dalla Chiesa, che non si occupò solo della parte palermitana dell’isola ma anche del versante etneo, come ben spiega Ardita nel capitolo che è emblematicamente intitolato: il generale. La sua netta cognizione della penetrazione della malavita nei poteri forti e all’interno dell’imprenditoria fu uno dei motivi della solitudine estrema in cui fu lasciato e dell’indignato risentimento dei cavalieri del lavoro catanesi. Intuizioni che furono poi accolte da Falcone. Il generale era consapevole di giocare una partita politica e lottò fino alla fine per conseguire il suo obiettivo.
Interessante l’intreccio tra mafia e imprenditoria che Ardita traccia nel capitolo dedicato ai cavalieri e molto accurato anche il capitolo dedicato a Giuseppe Fava; il ritrovamento del suo corpo martoriato, l’insabbiamento messo in atto subito dopo sulle reali motivazioni della sua morte (si parlò di una questione di donne e gelosia), mentre una sorta di censura conveniente impediva a molti giornalisti dell’epoca di approfondire anche solo una delle inchieste che Fava aveva denunciato dalle pagine dei Siciliani. Un colpevole silenzio sulle reali motivazioni fu quello non solo della stampa locale ma ancor di più della parte istituzionale, tra magistrati e politici che fecero a gara per cercare motivazioni altre ad una vicenda che aveva un unico mandante: la mafia. Uno dei passaggi più importanti del capitolo è senza dubbio quello in cui l’autore scrive:
Le operazioni il più delle volte le facevano fare i mafiosi stessi, utilizzando le soffiate alla polizia per eliminare chi dava fastidio. Questa era la Catania degli anni Ottanta. Altro che trattativa. Esisteva un patto di ferro fra Stato e mafia e una sola parola d’ordine: volare basso. E così dopo la morte di Fava in città il malcontento iniziò a montare, insieme alla voglia di verità e di giustizia.
Nulla poteva più essere uguale a prima, l’esempio di Fava e dei suoi ragazzi aveva piantato dei semi nella coscienza di molti. Eppure il colpo di grazia doveva ancora arrivare, in quello Stato alla sbarra che caratterizzò gli anni Ottanta a partire dall’11 dicembre 1984, in cui l’onore di molte toghe e divise venne definitivamente offuscato dal sospetto, e in molti casi dalla certezza, di una fattiva collaborazione con la mafia. Intrecci ancora più solidi furono sugellati con la politica, mentre da una parte il boom economico creava a Catania il mito della “Milano del sud” i poteri politici, con la Dc in testa, governavano la vita e gli interessi dei gruppi più potenti, coltivando licenze come fossero funghi e creando due delle opere urbanistiche più inquietanti nel tessuto dell’intera città, Monte Po e il Villaggio Sant’Agata, periferie prive di servizi dove regnava il disagio, mentre nella girandola politica nulla sembrava contenere gli animi e le idee degli abitanti
Il loro bisogno di identità e di riscatto non trovava risposte adeguate nei partiti tradizionali e così veniva riversato altrove: ora nell’estremismo, ora nelle curve del tifo ultras e nei fenomeni di violenza sportiva.
Con l’inizio degli anni Novanta e l’avvento di personalità come quella di Falcone una ventata di aria nuova arriva nei palazzi di giustizia e tra quei 1000 ragazzini premiati dal concorso in magistratura ci sarà anche l’autore del libro, che diventa qui testimone oculare di una rinascita della magistratura, di un clima agguerrito che rompe col passato e di una serie di accorgimenti che condizionano la sua stessa vita, pur di restare fuori dalle dinamiche amicali e collusive degli anni precedenti.
Il rapporto con alcuni dei politici di quegli anni, sentiti durante gli interrogatori, ci racconta molto del sistema di potere in atto e di quanto questo avesse investito anche personalità di spessore, seppure dalla parte sbagliata. E tanto ci racconta anche di un sistema lento e paziente di ascolto di quelle dinamiche che investirono con Tangentopoli non solo Catania, ma l’Italia intera. Poi arrivano i collaboratori di giustizia, tra questi anche alcuni piccoli commercianti che avevano favorito i loschi affari mafiosi, intermediari più che protagonisti. Vicende agghiaccianti di pressioni psicologiche e il racconto di come il regime di favore per i collaboratori ne aveva fatto lievitare il numero. L’epilogo di questo lungo racconto, che trascina il lettore dentro il turbine di vicende che hanno lasciato la loro traccia sugli ultimi decenni di Cosa Nostra a Catania, ma soprattutto dentro un sistema, un modus operandi e un modo di condizionare la realtà, lo scrittore lo dedica al commissario Lizzio. Una figura di commissario molto attiva in quegli anni e che pagò con la vita il suo impegno; Ardita racconta come prendendo a pretesto il ritrovamento di una moneta che nulla aveva a che vedere con l’omicidio, si siano creati sospetti di collusione attorno a questo servitore dello Stato.
Era chiaro che si trattava di un particolare che non c’entrava niente con la scena del delitto. Ma su quello fu costruito tantissimo. Su quello lavorò la Catania peggiore, quella che passa il tempo a normalizzare e a tranquillizzare anche screditando i morti, perché non vuole che esistano eroi in questa città. Sì perché gli eroi dividono, suggeriscono scelte di rottura, impediscono le collusioni.
Storie di carnefici e di vittime, tante, tra le pagine di questo libro, dall’omicidio di un diciottenne che ravvede un’intera comunità e le dona forza di denuncia e coraggio, all’esempio dell'avvocato Famà, freddato da un commando. Fino ad arrivare a quella trattativa Stato-Mafia che è tema odierno nelle cronache nazionali, nell’intreccio che si nutre di rapporti istituzionali, nel paradigma di una mafia che si fa quasi protettrice, che si sostituisce allo Stato e con l’appoggio di una parte di esso, nella sicurezza garantita ai cittadini per passare inosservati, per dare a tutti l’illusione che non esista più illegalità, si ingigantisce sempre più, affina le sue armi, dà vita ad una criminalità 2.0, confluita tra le categorie del mercato e della finanza, invisibili eppure ovunque. Una città che oggi si presenta, dopo l’immobilità degli anni Novanta, desiderosa di riscatto; ma per farlo - è il monito di Ardita - bisogna che si svelino le dinamiche che hanno tenuto in pugno la città per anni, che la coscienza dei catanesi si risvegli e torni la voglia di combattere, che è uno degli elementi vitali di questa città, bellissima e complicata.
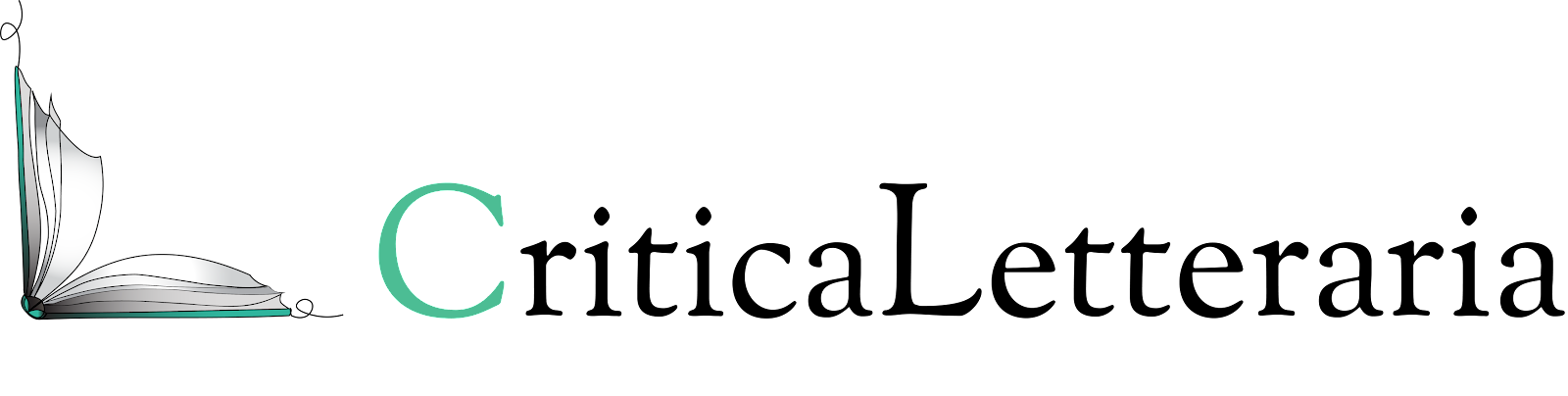


Social Network