Trilogia della città di K.
di Agota Kristof
Einaudi, 1998
pp.379
Agota Kristof nasce nel 1935 in un villaggio dell’Ungheria e resta nel suo paese fino al drammatico 1956, anno del famigerato intervento dell’Armata Rossa, intervenuta per soffocare la rivolta degli ungheresi contro l’invasione sovietica. Costretta a rifugiarsi in Svizzera, vi rimane per tutto il resto della sua vita, adottando il francese come lingua delle sue opere. Prima di capire il capolavoro della Kristof è necessario inquadrare la sua figura di scrittrice nel contesto sociale e nella storia di un paese che ha conosciuto la dittatura e in cui la guerra ha lasciato danni fisici e morali peggiori che altrove. Ed è fondamentale iniziare a familiarizzare con una scrittura che nasce dall’esigenza di dire il dolore, di raccontarlo senza retorica e senza divagazioni, ma con la sola caratteristica che il dolore conosce: la durezza.
Trilogia della città di K. parte come fosse una fiaba: all’inizio della guerra, in Ungheria, due gemelli sono affidati dalla Madre alla Nonna cattiva, anziana contadina che, invece di prendersi cura di loro, li maltratta e non nutre alcun affetto nei loro confronti. Il primo testo che compone la trilogia, Il grande quaderno, non è altro che il racconto della vita dei due bambini, Lucas e Claus, nella nuova realtà in cui sono stati catapultati, in cui tutto è il contrario di ciò che sembra e nella quale devono fare i conti con i pericoli del mondo esterno, imparando a interagire con gli adulti e con gli errori e le violenze che commettono.
Fiaba sì, ma “nera”, come sottolinea Rosetta Loy, perché se i bambini sono dei piccoli eroi e la Nonna è soprannominata “la Strega”, il mondo circostante è popolato da pochissime figure positive. L’occhio (non troppo inesperto e innocente) dei due bambini si posa su quanto di aberrante sono costretti a vedere quotidianamente. Ma i due protagonisti non hanno mai paura, al contrario, affrontano la selva della guerra e delle rivolte con freddezza, sapendo di poter contare solo l’uno sull’altro. Il primo libro della trilogia è strutturato secondo le modalità narrative della fiaba. Anche se si tratta di una fiaba contemporanea e cupa, vi si trovano gli elementi fondamentali del genere quali la divisione un po’ manichea tra buoni e cattivi, un percorso di formazione scandito da continui ostacoli, il fatto che i personaggi non siano mai contrassegnati da nomi propri, ma solo da nomi comuni o aggettivi.
E il tutto si svolge in un luogo indefinito, anch’esso mai nominato. L’unica cosa che è concesso sapere al lettore è che si tratta di un piccolo centro di un paese dell’Est Europa e che, vicino, c’è una grande città in cui cadono le bombe e da cui la gente scappa per mancanza di viveri. Il primo libro si conclude con la separazione dei due gemelli: Lucas resta in patria, Claus scappa in un altro paese, oltre la frontiera, in un mondo diverso, libero. I destini dei due fratelli si incroceranno nuovamente solo alla fine della trilogia. Nei due testi successivi, La prova e La grande menzogna, il lettore sa che i due protagonisti sono separati e segue quasi esclusivamente le vicende di Lucas, mentre incontrerà Claus solo a metà dell’ultimo libro. Ciò che rende interessante la trilogia è il fatto che la costruzione narrativa cambia nel corso delle tre parti. Il destino dei personaggi conoscerà una sua evoluzione, essi si rapporteranno a nuove figure, a volte tratteggiate brevemente, altre più profondamente indagate. Non si parla più di fiaba oscura, ma si entra pian piano nella zona di una narrazione più strutturata, un romanzo di avventura si direbbe, se solo non si trovassero inadeguate le etichette: Trilogia della città di K. sfugge a una classificazione rigida e si configura come genere di confine.
Muta la struttura narrativa ma mai lo stile dell’autrice, sempre asciutto, tagliente, ossessivamente scandito da punti fermi che frammentano il testo in micro-proposizioni e lo costruiscono a singhiozzi, quasi a dare al lettore l’idea di un dolore che si accumula su un altro e poi su un altro ancora, fino all’epilogo. Una prosa affilata come lama di coltello, “che ha l’andatura di una marionetta omicida”, come ha scritto Manganelli. Nessun altro stile poteva prestarsi al racconto di una vicenda simile meglio di quello utilizzato dalla Kristof. Ed è l’elemento che al lettore rimane più impresso al termine della lettura: quella parola che si fa spazio sullo sfondo di una realtà di fame e di morte, senza grandi pretese o elucubrazioni, ma ponendosi sulla scena per quel che è: il verbo della paura, della morte, della guerra, dei legami spezzati.
Ma “Trilogia della città di K.” è grande per un altro motivo: nelle ultime cento pagine l’autrice ha l’abilità di capovolgere tutto ciò che chi legge ha raccolto e che dava ormai per scontato per raccontare un’altra versione dei fatti e ripartire dall’inizio con una narrazione che sa abilmente mescolare presente e passato, facendo perdere il senso dell’orientamento. Il lettore, per qualche pagina, si sentirà come Lucas e Claus, in una terra straniera, senza punti di riferimento. È uno dei capisaldi della grande letteratura novecentesca: l’idea che il narratore violi il patto con il lettore per condurlo su terreni instabili, diversi da quelli che lui si aspetta o conosce, per raccontargli una storia che è composta da molte storie insieme, una versione dei fatti plurima, dove i confini tra verità e menzogna diventano labili. E il tutto diventa ancora più interessante se si pensa che il romanzo della Kristof scorre parallelo a quello che i due gemelli scrivono e si trasmettono a vicenda.
Un metaromanzo che, insomma, non fa più capire in quale libro ci troviamo: in quello dell’autrice, in quello di Lucas, di Claus o, semplicemente, nella grande narrazione della storia? E Claus e Lucas sono veramente due gemelli o le due facce di una stessa persona? Dare una risposta unica sarebbe troppo banale e, perché no, contrario ai presupposti della letteratura del ‘900 che rinuncia a fare della nostra percezione dei fatti quella oggettiva. Ed è una letteratura che ti lascia inerte, alla fine, incerto nel ripercorrere tutte le tappe della narrazione alla ricerca dell’anello mancante, quando in realtà l’unica rappresentazione dei fatti che l’uomo può esprimere è, di per sé, mancante.
Un metaromanzo che, insomma, non fa più capire in quale libro ci troviamo: in quello dell’autrice, in quello di Lucas, di Claus o, semplicemente, nella grande narrazione della storia? E Claus e Lucas sono veramente due gemelli o le due facce di una stessa persona? Dare una risposta unica sarebbe troppo banale e, perché no, contrario ai presupposti della letteratura del ‘900 che rinuncia a fare della nostra percezione dei fatti quella oggettiva. Ed è una letteratura che ti lascia inerte, alla fine, incerto nel ripercorrere tutte le tappe della narrazione alla ricerca dell’anello mancante, quando in realtà l’unica rappresentazione dei fatti che l’uomo può esprimere è, di per sé, mancante.
È per tutti questi motivi che “Trilogia della città di K.” merita di essere nominata tra i capolavori della letteratura contemporanea: perché l’autrice usa una prosa degna di quella del migliore Carver, perché riflette la crisi e il disfacimento della guerra raccontandoli per quelli che sono, senza una parola di troppo; restituisce una visione storica ma allo stesso tempo sa raccontare il dolore senza tempo dell’uomo e ogni pagina è intrisa di un senso di solitudine primordiale; perché è un elogio della scrittura come arte che, in parte, garantisce la sopravvivenza (E quando avrai troppa pena, troppo dolore, e se non ne vorrai parlare con nessuno, scrivi. Ti aiuterà.).
Ma, infondo, neanche la scrittura riesce a dare piena consolazione e l’opera si conclude come una favola senza lieto fine, proprio come era iniziata, rinchiudendo i personaggi (e il lettore) in un vortice. E l’autrice non manca di metterci in guardia:
Incitando il cavallo, Joseph grida: - Stia attento, Lucas! L'amore a volte è mortale.
Claudia Consoli
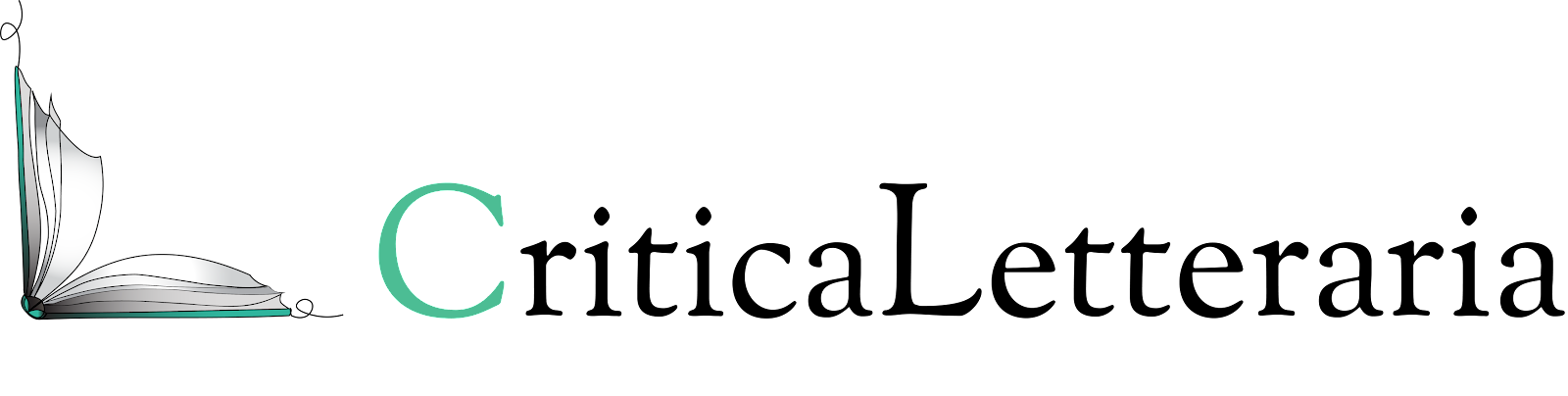

Social Network