La sequenza mirabile
di Giulio Leoni
Oscar Mondadori, Milano 2008
pp. 258
€ 9,50
di Giulio Leoni
Oscar Mondadori, Milano 2008
pp. 258
€ 9,50
Il nuovo libro di Giulio Leoni può dirsi un esempio riuscito, anche se non immediatamente dichiarato, di “contaminazione fra i generi”: lo storico, l’esoterico, il giallo, il thriller, ma in qualche modo anche il Bildungsroman, la satira di costume, il racconto in presa diretta sul precariato intellettuale giovanile, e forse molto altro ancora. Nell’arco di tredici capitoli (numero forse non casuale in un romanzo che, tra il serio e il faceto, offre ampi scorci di cultura dell’occulto) si snoda una trama complicata e a volte difficile da seguire, anche a causa dello sguardo ammiccante dell’autore, del continuo spostamento di focalizzazione.
Il protagonista, un io narrante affine a Leoni per biografia, professione e dati anagrafici (si chiama Giulio ed è un giovane scrittore di gialli, anche se costretto ad attività collaterali come la redazione di tesi a pagamento), riceve la strana visita di una coppia padre-figlia, Ermete ed Amaranta Cimbro, che sembra appena uscita da un episodio della famiglia Addams. La richiesta, poi, è ancor più singolare dei personaggi che la presentano: ritrovare, sulle tracce di un manoscritto mutilo che si rivelerà ben presto apocrifo e inutile in ogni sua parte, la formula inventata da un oscuro matematico di fine Ottocento per vincere al gioco d’azzardo (la Sequenza Mirabile, che dà il titolo all’opera).
La formula porta con sé una scia di mistero e di sangue, a partire dalla sorte dell’avo (arricchitosi con loschi traffici ai tempi dell’impresa di Fiume e ufficialmente morto suicida) e dei suoi collaboratori senza scrupoli (trapezisti in un circo dell’epoca, precipitati nel corso di un’acrobazia senza rete). Queste morti misteriose sembrano ricominciare con l’avvio della ricerca di Giulio e con l’ingresso di alcuni personaggi chiave: uno studioso interpellato all’uopo; un cugino del richiedente, rintracciato e divenuto frate; infine un pretendente dell’enigmatica Amaranta Cimbro, dedito a singolari esperimenti di ricostruzione storico – tecnologica inerenti all’epoca del futurismo.
La frequentazione fra Giulio e i Cimbro si fa via via più serrata, anche a causa dell’ambigua attrazione che il protagonista prova per Amaranta, una donna dal fascino malsano che si rivela presto il vero motore della vicenda: appare ammalata di un male incurabile, che Ermete tiene a bada con intrugli alchimistici assai costosi, al punto da obbligare la figlia a saltuari incontri mercenari e il padre alla ricerca di disperati espedienti. All’approfondirsi dell’amicizia fra i tre corrisponde un progressivo degrado della vita intellettuale e delle abitudini di vita del protagonista, a metà fra il traviamento dantesco e la descrizione nosologica di un’astenia conclamata. Nel frattempo, però, la vicenda si complica, allontanandosi dall’apparente punto di partenza: la maledizione non parte dalla Sequenza Mirabile, rivelatasi sempre più risibile; parte invece da un carico navale d’oro, destinato a finanziare una sorta d’aborto di dittatura protofascista a Fiume per opera di un allora ufficiale di Marina, celato sotto il nome in codice “Grillodoro”. Il furto fraudolento, non l’azzardo avventato, aveva decretato la fine del capostipite Cimbro e dei suoi uomini. E sarà una risorta Nemesi transgenerazionale, non un’astratta maledizione numerica, a decretare ai giorni nostri la fine dei ricercatori implicati nella ricerca della pseudo-formula.
La vicenda è ambientata fra una Roma in piena decadenza morale e l’incursione in una Venezia carnascialesca che ne rappresenta l’alter locus, in un fine gioco di rimandi anche speculare. Incursione malinconica, perché proprio la tratta Roma-Venezia, svoltasi in un wagon lit di sapore vagamente christiano e interrotta a Firenze dal dietro-front di Amaranta, sancirà la definitiva impossibilità dell’amore fra i due protagonisti e la consumazione della fine, già da tempo annunciata, della donna. Ma vi sono anche scorci di gustosa satira di costume, come l’adunata di tutti i personaggi principali alla riunione sociale, con relativa seduta spiritica, del capitolo quinto, in cui si compendia la descrizione di tutti i vizi della pseudo-intellettualità parassita d’ogni tempo e luogo. C’è un continuo rimando, inoltre, fra la formula matematica che va smarrendosi (in senso, in valore e nella stessa consistenza ontologica) e un’altra Formula, a sua volta simbolo di un altrove non raggiunto: la miscela filosofale che dovrebbe salvare la vita d’Amaranta e che infine la perde, complice l’invisibile mano omicida che muove le fila della vicenda coeva al protagonista. Se dietro la Sequenza Mirabile si celava un carico d’oro trafugato, fuso e disperso nei meandri della Storia, dietro il taumaturgico oro filosofale sonnecchia soltanto un vile liquame venefico.
Viene il dubbio, fra omicidi, violenze, degradi psico/ambientali e morti quasi accidentali, che l’obiettivo mancato sia proprio la ricerca alchemica del vero Sé: quello che il protagonista, nella squallida solitudine finale, forse non è riuscito a completare. Che la platonica storia d’amore fra Amaranta e Giulio, oltre il cinismo, il distacco e il disgusto, di sapore a tratti un po’ tarchettiano, inauguri una sorta di moderna ripresa straniata della dialettica Eros/Thanatos. E che in mezzo a vizi e vendette, rinnovati attraverso le generazioni come un fato estenuato, la morte e l’oblio siano davvero soltanto apparenze:
La catena del male potrebbe allora non essersi interrotta e l’inquietante eredità proseguire sotto spoglie metamorfosate, impalpabili e perenni; come le ceneri della donna che Giulio, rimasto unico custode e contravvenendo all’ordine burocratico d’inumazione, disperde infine nel vento della campagna romana, da un altro anonimo treno in corsa.
«un’eccessiva dilatazione dei tempi, un’esagerazione» (pag. 256).
La catena del male potrebbe allora non essersi interrotta e l’inquietante eredità proseguire sotto spoglie metamorfosate, impalpabili e perenni; come le ceneri della donna che Giulio, rimasto unico custode e contravvenendo all’ordine burocratico d’inumazione, disperde infine nel vento della campagna romana, da un altro anonimo treno in corsa.
Alessandra Paganardi
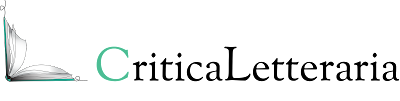



.png)














