Il cane di Giacometti
di Stefano Raimondi
Marcos y Marcos, 2017
pp. 107
€ 18,00 (cartaceo)
Sezione prima: "Non è vero, non è successo mai".
Non è facile individuare una narrazione nella poesia di Raimondi: ogni testo è un continuo ritorno al tema centrale, doloroso, dell'abbandono. Di questo abbandono il cane di Giacometti, "spettro che sa essere l'esaltazione suprema della solitudine", diventa correlativo oggettivo più che simbolo. È compagnia materica e a tratti inquietante che "mi scodinzola accanto; [...] m'insegue, per giorni interi, tra notti lasciate qui a tremare". Quello descritto da Raimondi è un cosmo negativo, fatto di spazi vuoti, ambienti chiusi, cose transeunti e solo sporadiche aperture (le finestre sono per lo più sbarrate). "Non ci sono", "non esiste", "non è", "non sono", "mai"... il lessico prevalente si riferisce a un universo di negazioni, marcato dall'impersonalità (quasi non si avesse il coraggio di guardarsi dentro), dove la solitudine morde come un cane rabbioso (e rimangono spesso solo paura, buio, tremori).
Non è un caso che la reazione a questo stato per il soggetto sia una cieca brama di sopravvivenza, un ostinato aggrapparsi al poco che è concesso, fosse anche solo un relitto alla deriva:Lasciare che il giorno passi come quando fino all'ultimo si resta aggrappati a un legno: a un coro d'unghie. E tu resti vicino a qualcosa che ti tiene che sapevi dove ritrovare spaccato inzuppato, salvato appena.
Nell'ambito di una poetica che si può senza timori definire residuale, del resto, anche un legno spaccato e inzuppato può salvare.
Sezione seconda: "Il fiato tondo dei tombini".
Nella seconda sezione, in uno spazio urbano che si va sempre più definendo e sempre più acquista consistenza, inizia il vagabondare inquieto dell'io lirico. La poesia apre uno squarcio sull'alterità, su un tu dolorosamente assente, su un'umanità infelice e peregrina con cui il soggetto si può identificare. Si apre anche la strada al ricordo, all'esplorazione - che procede a tentoni, con prudenza dolente e inquieta -, di un fallimento relazionale. La metropoli grigia e piana (vi si aprono i buchi delle tane e delle cantine, i baratri dei tombini, le strettoie dei cunicoli) diventa il luogo perfetto per l'elaborazione del lutto in un andare disordinato da un angolo all'altro, tra muri e ringhiere che non sono in grado di soffocare definitivamente il sogno. Al buio subentra talvolta una luce accecante, la possibilità forse di comprendere, e la solitudine diventa un'occasione per ridefinirsi, per scoprire qualcosa su di sé (se si è angeli o mendicanti).
Ci sono mezzogiorni che lo raccontano il vuoto, la meridiana a picco nel passaggio stretto dei dormienti. Si resta così, a volte, senz'ombra come per provare a rimanere soli per sapere come si diventa altro e altro ancora.
Negli ambienti attraversati con stupore attonito c'è una storia da raccontare, che ha segnato il passato e mina il presente. Così a volte, paralizzati, "restiamo così [...]: fermi come evidenze testarde del dolore. E il sole non benda più".
Sezione terza. "Il pianista zoppo e la gobba claudicante"
Insieme alla storia arriva la speranza, lo spiraglio di una guarigione che può arrivare solo tramite l'attesa. Magari stando accanto a qualcuno di zoppo quanto noi, che condivida con noi ferite e smarrimenti, che al nostro fianco sappia aspettare. Ci sono gli errori passati che diventano consigli per rimedi futuri, c'è un vocabolario che pian piano si dischiude: esserci, bastare, fiducie, restare, perdoni, guarigioni, baci, carezze, respiri... la memoria fa meno male, anche se l'incontro con l'altro individuo resta qualcosa di famelico ed egoista, un tenersi a galla a vicenda per il tempo che è dato:
Si arriva sempre nella vita di qualcuno: in un punto a corto di saliva e ci si resta per sentire le crepe scendere, spaccarsi come una carezza furibonda, da gridare.
Sezione quarta. "Cuore-atlante"
Dove il cuore si fa mappamondo in movimento, in grado di accogliere il nuovo, di superare ogni prova:
È inutile avere paura. Il cerchio inizia, finisceprimo poi ricomincia come un mappamondo con un dito puntato contro.
Dalla topografia dell'abbandono si passa alla fenomenologia dell'abbandono e dei suoi postumi. Il dolore è inevitabile, connesso all'esistenza, al diventare grandi. Solo attraverso la resa, l'accettazione di una verità che fa male eppure deve essere esposta senza remore o timori ("la paura [...] è quando qualcuno dice esattamente il nostro nome per intero"), è forse possibile un nuovo inizio. Un inizio da bambini che giocano e sognano, contano i desideri con mani piccole ma precise, imparano il sangue a proprie spese, continuano a fissare la luce per non vedere il buio intorno.
Carolina Pernigo
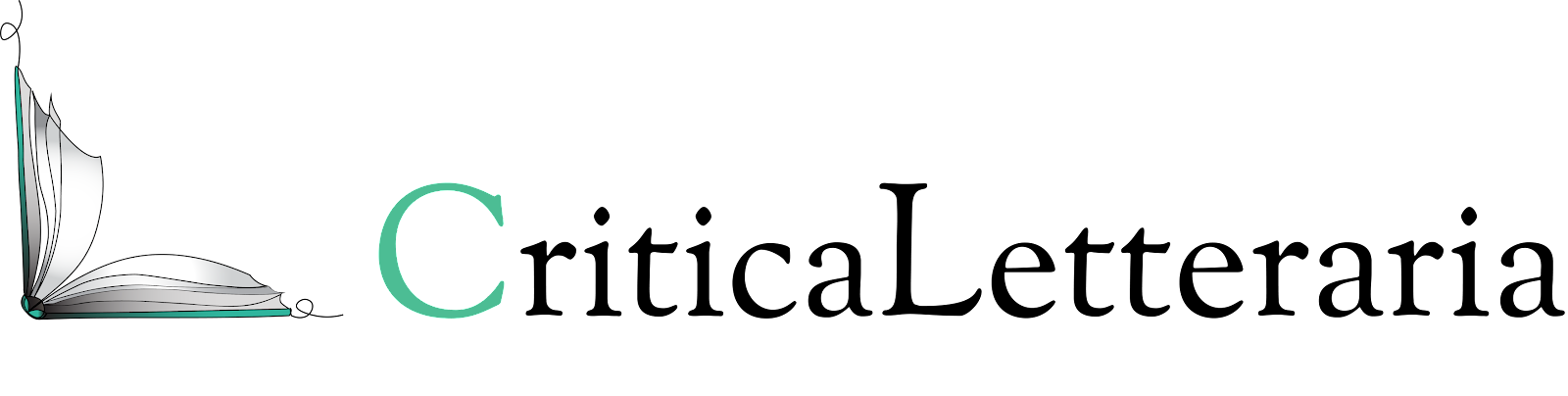


Social Network