Zadie Smith
"Libellule" Mondadori, marzo 2015
Traduzione italiana di Silvia Pareschi
pp. 72
€ 10,00
Ognuno di noi ha i suoi autori feticcio. Non intendo necessariamente gli autori preferiti, di cui ogni pagina letta e riletta ci sembra ogni volta la miglior cosa mai pubblicata fino a quel momento, con cui proviamo un grado incredibile di empatia e che in qualche modo ci rassicurano; ma quegli autori, di solito poco più di un paio, di cui non possiamo fare a meno di seguire ogni nuova pubblicazione o intervista certi che, nel bene e nel male, sarà l’ennesima occasione per spingerci a riflettere e magari mettere in dubbio le nostre – effimere – certezze. Non sempre ne condividiamo le idee, ci entusiasma la storia, o proviamo empatia con le loro parole, eppure torniamo ancora una volta lì, ipnotizzati dal fascino intellettuale che suscita in noi proprio quello scrittore in particolare. Personalmente ci sono casi in cui autori prediletti ed autori feticcio coincidono (un esempio su tutti: Virginia Woolf, che non mi stanco mai di leggere e rileggere, specie come saggista, di cui da sempre mi affascina anche il “personaggio” ) e altri che rientrano meglio nella seconda categoria, di cui seguo con estremo interesse interventi e pubblicazioni consapevole del fatto che potrebbero deludermi o infastidirmi con la propria posizione intellettuale, la propria visione del mondo e della vita. Penso a Franzen, David Foster Wallace, Salinger, Caitlin Moran, solo per citarne alcuni: ho amato follemente alcuni loro scritti e con la stessa passione ne ho detestato altri, mi entusiasmano alcune prese di posizione sul mondo che ci circonda così come altre mi suscitano un’antipatia assurda. Eppure, ogni volta che trovo online un’intervista, scopro una nuova pubblicazione o un dibattito intorno all’autore, difficilmente resisto proprio perché consapevole della particolare capacità che hanno di suscitare in me sentimenti contrastanti e la riflessione svincolata da sentimentalismi o inutili difese di parte.
Zadie Smith rientra nel gruppo di autori feticcio. Denti bianchi è il romanzo con cui ho scoperto questa scrittrice londinese di famiglia giamaicana e che, ancora, rimane per me uno dei suoi libri più riusciti in cui ha esplorato molte delle tematiche che sono diventate nel tempo quello che pare essere il suo campo d’indagine prediletto. Autrice di romanzi, saggi – tra cui due a mio modesto parere fondamentali nella bibliografia della Smith: Cambiare idea e Perché scrivere – e racconti, vivace intellettuale sempre interessante da seguire a festival, presentazioni ed eventi cui partecipa con una certa frequenza anche in Italia dove ha vissuto per qualche tempo e di cui pare conservare un piacevole ricordo. Non sempre sono d’accordo però con le sue prese di posizione, in alcuni sporadici casi noto una certa vena di snobismo nelle sue parole e sarebbe interessante credo vederla alla prova con qualcosa di nettamente diverso da quello su cui ha scritto finora, abbandonando cioè i temi fino a questo momento più vicini alla propria esperienza umana ed intellettuale per sorprendere il lettore con un nuovo punto di vista, così da liberarsi almeno per un po’ dal confronto inevitabile con i romanzi che l’hanno resa celebre.
Ma, come dicevo, nonostante qualche volta capiti che mi trovi in disaccordo con ciò che scrive o sia ansiosa di leggere qualcosa di completamente diverso da quello a cui ci ha abituati finora – e ad una come la Smith senza dubbio il coraggio per cambiare, abbandonare la comfort zone per trovare un punto di vista differente non manca di certo – anzi proprio per questa sua capacità di suscitare nella sottoscritta curiosità, interesse sincero e riflessione, Zadie Smith è senza dubbio uno dei miei autori cult e una delle voci più interessanti nel panorama letterario contemporaneo su cui la critica – anglosassone soprattutto – ha giustamente speso molte parole in questi anni ma sulla cui ricezione nel nostro paese nutro invece qualche dubbio: la Smith è senza dubbio un’autrice piuttosto letta e nota anche in Italia, come dimostrano la diffusione delle sue opere, la presenza ai festival, le interviste e gli articoli che appaiono di frequente su riviste e quotidiani; ma con quale livello di analisi sia affrontata la lettura della Smith rispetto a quanto accade per esempio nel Regno Unito o negli Stati Uniti è qualcosa su cui forse varrebbe la pena riflettere, in altro momento, in maniera più approfondita.
E in questo senso è quindi in qualche modo curioso, oltre che ovviamente un segnale positivo, il fatto
 |
| Work in progress (foto di Debora Lambruschini) |
che Mondadori abbia pochi giorni fa pubblicato in cartaceo ed ebook L’ambasciata di Cambogia, un racconto lungo originariamente apparso sul New Yorker nel 2013, al quale speriamo seguano altre pubblicazioni di questo tipo (e in effetti viene piuttosto spontaneo interrogarsi sulla scelta di pubblicare un solo, seppur lungo, racconto anziché pensare un’edizione contenente un numero maggiore di scritti della Smith), alla luce anche della riscoperta negli ultimi anni del genere. Nello spazio di poco meno di una settantina di pagine, la Smith torna ancora una volta ai temi che contraddistinguono la sua produzione narrativa ma lo fa mediante la forma racconto riuscendo a creare personaggi e quartieri vivi, lasciando il giusto spazio al non detto e alle interpretazioni del lettore in ciò che c’è stato prima della storia di Fatou – la protagonista del racconto – a Londra, quella parte del quotidiano non svelato, e ciò che sarà dopo la parola fine.
Non è ovviamente il caso di soffermarsi a lungo sulla trama per non privare il lettore del piacere di scoprirla da sé, ma ci sono sicuramente alcuni punti interessanti su cui vale la pena riflettere per un momento. Innanzitutto il punto di vista scelto per raccontare questa storia: principalmente è la voce di Fatou, la giovane donna che dalla Costa d’Avorio era giunta anni prima a Londra, nel quartiere multietnico di Willesden (lo stesso in cui vive, quando non a New York, Zadie Smith) come domestica di una famiglia benestante di pakistani; ogni giorno passa davanti all’ambasciata cambogiana e ogni giorno sente, al di là dell’alto muro di recinzione, il rumore delle partite a badminton, le racchette che colpiscono il volano di cui ogni tanto intravede la forma volare in alto. Percorre abitualmente quella stessa strada, in un’ora di libertà rubata, in quel breve tempo solo per sé durante il quale nuota instancabile nella piscina del club di cui i Derawals sono soci (e inconsapevoli degli ingressi omaggio che Fatou sottrae loro per poter usufruire della piscina). Lungo la strada, impegnata a nuotare o negli sporadici momenti di socializzazione della giovane donna, ne seguiamo il pensiero intuendone la storia. Poi, ad intervallare il racconto – suddiviso in 21capitoli/punti come nel già citato gioco del badminton - la voce degli abitanti del quartiere che osservano con curiosità mista a diffidenza l’edificio celato dal muro insolitamente alto per un’ambasciata e quella ragazza che ogni giorno compie lo stesso percorso.
L’ambasciata che è il pretesto per riflettere sull’altro e su ciò che, nella sua diversità, ci spaventa:
C’è una casa con un enorme elefante rosa davanti alla porta, che sembra fatto di tessere di mosaico. C’è un convento di suore cattoliche con una sola macchina, una Ford Focus rossa, parcheggiata davanti. C’è un istituto sikh. C’è una villa con piscina in stile falso Tudor che Mickey Rooney affittò per una stagione, quando recitava nel West End quindici estati fa. Quella villa sorge davanti a una squallida casa di riposo, dove ogni tanto si vede qualche anima afflitta, a malapena coperta dalla vestaglia, ferma sul suo minuscolo balcone a fissare la chioma dei castagni. Perciò gli edifici insoliti non ci sono affatto estranei, qui a Willesden e Brondesbury. Eppure l’Ambasciata di Cambogia ci ha un po’ sorpresi. Per qualche motivo, però, non è il tipo giusto di sorpresa.
È quindi ancora la Londra multietnica dove la storia del singolo è il pretesto per riflettere sul tema dell’integrazione, tra difficoltà, ingiustizie e diffidenza e molta solitudine, in cui questa volta è l’immigrato che in qualche modo si è più o meno integrato a reagire con sospetto e scarsa umanità nei confronti dell’altro, dello sconosciuto. Eppure, nonostante le difficoltà, il peso del passato e nuovi ostacoli, il racconto di Fatou è anche pieno di innocente umana speranza e la forza di questa giovane donna infonde alla storia un’interessante prospettiva sul tema trattato.
Debora Lambruschini
In occasione dell'uscita di NW (leggi la recensione), avevamo incontrato Zadie Smith a Roma: leggi qui.
In occasione dell'uscita di NW (leggi la recensione), avevamo incontrato Zadie Smith a Roma: leggi qui.
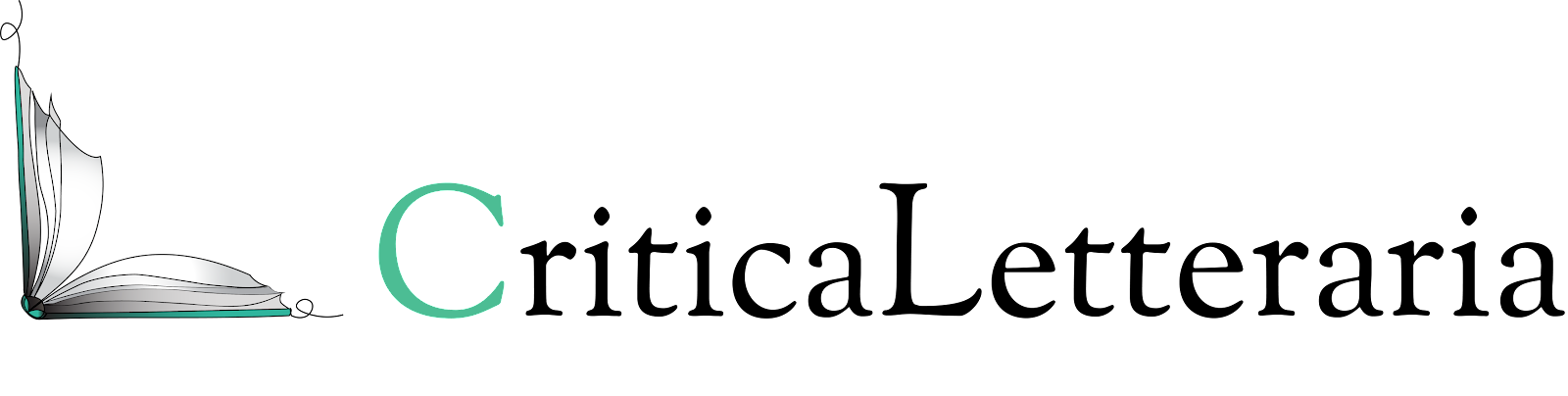

Social Network