Esattamente cinquecento anni fa, il 10 dicembre 1513, Niccolò Machiavelli scrive una lettera al suo amico Francesco Vettori, ambasciatore presso la curia di Leone X. Il grande autore che, nei mesi appena precedenti, ha scritto di getto il trattato De principatibus (noto ai più come il Principe), racconta al suo amico le sue giornate all'Albergaccio, casa di campagna vicino a San Casciano di Pesa in cui si è ritirato, in esilio, in attesa di tornare in favore presso i Medici e di ottenere qualche carica a Firenze.
Questa epistola è una tra le lettere più belle che siano mai state composte, e in cui un lettore moderno possa imbattersi. Primo, perché è tutta innervata di letterarietà. Comincia con una scherzosa citazione a memoria dai Trionfi di Petrarca ("Tarde non furon mai grazie divine": Niccolò attendeva con grande ansia le lettere del suo potente amico), ma la letteratura è sempre dietro l'angolo, anche quando si parla di passeggiate per i boschi: Niccolò cammina carico di gabbie, ma si paragona a Geta, servo protagonista della novella quattrocentesca Geta e Birria, che aveva l'incarico di portare i libri del padrone.
Io mi sto in villa; e poi che seguirno quelli miei ultimi casi, non sono stato, ad accozzarli tutti, venti dí a Firenze. Ho infino a qui uccellato a' tordi di mia mano. Levavomi innanzi dí, impaniavo, andavone oltre con un fascio di gabbie addosso, che parevo el Geta quando e' tornava dal porto con e libri d'Amphitrione; pigliavo el meno dua, el più sei tordi. E cosí stetti tutto settembre.
Secondo, perché nel vivace, saporito racconto di Niccolò Macchiavelli riusciamo a rivivere, a cinquecento anni di distanza, tutta la gioiosa trivialità quotidiana di un borgo del XVI secolo. Possiamo davvero farci una passeggiata con Niccolò, farci raccontare dai suoi dipendenti e vicini le loro beghe, litigare con uno di loro che vuol farti pagare dieci lire in più perché - così sostiene - le aveva vinte in un gioco a carte quattro anni prima. Attenzione, però, a non dimenticare il fondo d'amara ironia con cui ci viene raccontato tutto questo. «Io mi sto in villa; così Niccolò inizia il suo racconto. Per altri fiorentini del suo tempo, e dei tempi passati, vivere in villa voleva dire allontanarsi dagli affari e dal tumulto della vita della città per trovare la pace negli studi, nella meditazione e negli svaghi campestri. Per Niccolò è una rinuncia forzata alla vita che ama» (M. Viroli, Il sorriso di Niccolò, Laterza 1998).
Io mi lievo la mattina con el sole, e vòmmene in un mio bosco che io fo tagliare, dove sto dua ore a rivedere l'opere del giorno passato, e a passar tempo con quegli tagliatori, che hanno sempre qualche sciagura alle mani o fra loro o co' vicini. E circa questo bosco io vi harei a dire mille belle cose che mi sono intervenute, e con Frosino da Panzano e con altri che voleano di queste legne. E Frosino in spezie mandò per certe cataste senza dirmi nulla; e al pagamento, mi voleva rattenere dieci lire, che dice aveva havere da me quattro anni sono, che mi vinse a cricca in casa Antonio Guicciardini. Io cominciai a fare el diavolo, volevo accusare el vetturale, che vi era ito per esse, per ladro. Tandem Giovanni Machiavelli vi entrò di mezzo, e ci pose d'accordo. Batista Guicciardini, Filippo Ginori, Tommaso del Bene e certi altri cittadini, quando quella tramontana soffiava, ognuno me ne prese una catasta. Io promessi a tutti; e manda'ne una a Tommaso, la quale tornò a Firenze per metà, perché a rizzarla vi era lui, la moglie, la fante, i figlioli, che pareva el Gaburra quando el giovedí con quelli suoi garzoni bastona un bue. Dimodoché, veduto in chi era guadagno, ho detto agli altri che io non ho più legne; e tutti ne hanno fatto capo grosso, e in specie Batista, che connumera questa tra le altre sciagure di Prato.Il togato ammonitore del Principe sta in mezzo alla gente, ma cerca anche la solitudine, e lo fa sempre con un libro sotto braccio. Legge gli amori altrui - Dante, Petrarca, Tibullo o Ovidio - e si ricorda con piacere dei propri, ma la arrivata l'hora del desinare torna a casa, dalla sua brigata (la sua famiglia) e poi si reimmerge nella folla: parla con gli altri, chiede, s'informa, gioca all'osteria coi gaglioffi del borgo. Gridano così tanto da farsi sentire dal paese vicino, e questo dà a Niccolò un piacere quasi catartico, gli sembra di "trarre el cervello di muffa", di dargli ossigeno, gli pare quasi di dimenticarsi di sé:
Transferiscomi poi in sulla strada, nell'hosteria; parlo con quelli che passono, dimando delle nuove de' paesi loro; intendo varie cose, e noto varii gusti e diverse fantasie d'huomini. Viene in questo mentre l'hora del desinare, dove con la mia brigata mi mangio di quelli cibi che questa povera villa e paululo patrimonio comporta. Mangiato che ho, ritorno nell'hosteria: quivi è l'hoste, per l'ordinario, un beccaio, un mugnaio, dua fornaciai. Con questi io m'ingaglioffo per tutto dí giuocando a cricca, a trich-trach, e poi dove nascono mille contese e infiniti dispetti di parole iniuriose; e il più delle volte si combatte un quattrino, e siamo sentiti non di manco gridare da San Casciano. Così, rinvolto in tra questi pidocchi, traggo el cervello di muffa, e sfogo questa malignità di questa mia sorta, sendo contento mi calpesti per questa via, per vedere se la se ne vergognassi.
Ma giunge la sera, e con essa il terzo motivo per cui questa lettera riesce ancora a donare tanto a un lettore del 2013. Il Niccolò del giorno è stato, anche se sempre con un libro in testa o sotto braccio, un uomo immerso nel fango caotico delle cose, negli affari, nei negotia quotidiani che affannano dall'alba al tramonto. Chiusa la porta di casa, però, avviene una trasformazione: proprio in sull'uscio, sulla soglia del suo studiolo, Niccolò sveste quei panni infangati e ne indossa di altri, reali e curiali, degni cioè di una corte e di incontri regali. Lo attendono, infatti, grandi amici del passato: i classici. Il racconto di questo grande incontro è debitore di tanta letteratura precedente, primi fra tutti Seneca e Petrarca. Ma Machiavelli va oltre, perché l'incontro coi libri è descritto come un rapporto sacro ma confidenziale, liturgico eppure amicale, in cui gli antiqui huomini ricevono amorevolmente Niccolò e lo nutrono con le proprie parole e lui, senza alcuna vergogna, li interroga, dimenticando ogni preoccupazione.
Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio; e in sull'uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito condecentemente, entro nelle antique corti delli antiqui huomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch’io nacqui per lui; dove io non mi vergogno parlare con loro e domandarli della ragione delle loro azioni; e quelli per loro humanità mi rispondono; e non sento per quattro hore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi transferisco in loro.
«In queste righe di straordinaria bellezza Machiavelli rivela il suo animo, mostra tutta la sua grandezza interiore. Quando si toglie, prima di entrare nel suo studio, i panni con cui è andato per boschi e nell'osteria, si toglie anche la maschera che egli stesso si mette, perché non può più essere se stesso e deve essere invece come la Fortuna vuole che sia, ovvero volgare e misero, nella speranza che la bizzarra dea si stanchi del suo gioco crudele. Quello che entra nello scrittoio [...] è il vero Niccolò che può finalmente ragionare della sua arte, ovvero l'arte di fondare, conservare, redimere Stati» (Viroli). Il prodotto di questo ricco nutrimento, di questa frequentazione strettissima che ha la forma di una vera e propria amicizia, non è infatti soltanto la consolazione (così, forse avrebbe concluso Seneca). Dal capitale raccolto da Machiavelli nasce proprio il suo capolavoro, il Principe:
E perché Dante dice che non fa scienza sanza lo ritenere lo havere inteso - io ho notato quello di che per la loro conversazione ho fatto capitale, e composto uno opuscolo De principatibus...
Si potrebbe concludere, sul finire di questa lettera immortale, che la grande letteratura è sempre figlia della letteratura. Ma non sarebbe corretto. Lo è, forse, una cosa un po' diversa: che ogni grande attività intellettuale, che sia o meno letteraria, è figlia dei padri che elegge attraverso una grande, inesausta ricerca.
Laura Ingallniella
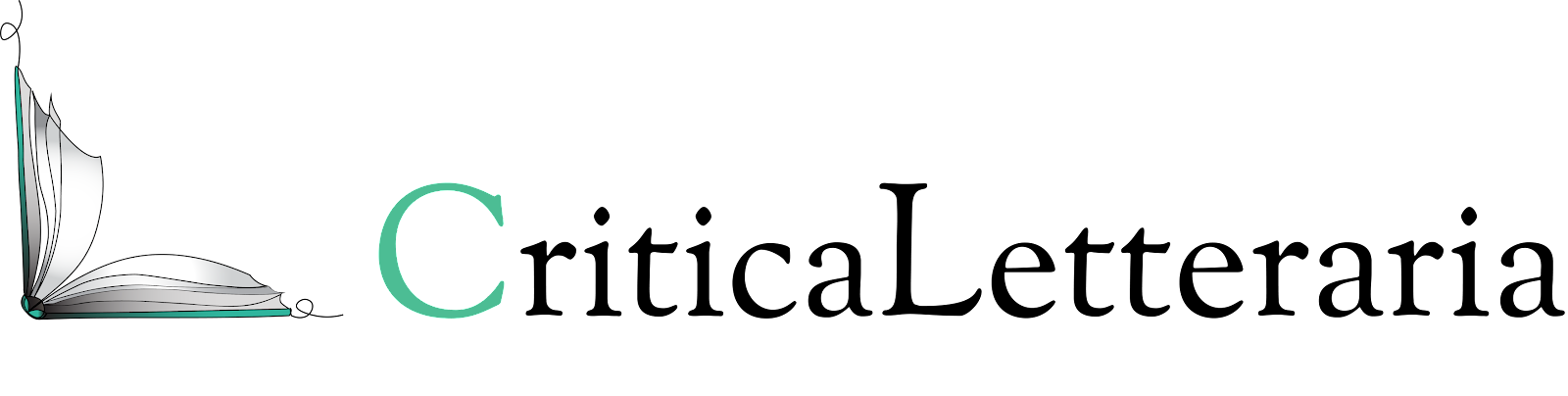

Social Network